Tutto comincia con un rap sincopato: musica ossessiva per fare da colonna sonora ad azioni di guerra contro civili inermi. Ecco l’incipit di “Necroware”, primo racconto del mio nuovo ebook. E se volete, c’è pure la canzone di Fatboy Slim…
![]() Right about now
Right about now
The funk soul brother
Check it out now
The funk soul brother…
The Rockafeller Shank – Fatboy Slim
Stevan appoggiò la fronte sulla corteccia nuda e aggricciò le labbra. Soffiò un’imprecazione tra i denti marci. Non riusciva a escludere il dolore dalle sue terminazioni nervose. Gli altri della squadra ci riuscivano senza problemi, lui no. Boccheggiò in cerca d’aria. Dall’avambraccio ferito spurgava un liquido denso e appiccicoso, del quale non riuscì neppure a intuire il colore. Alzò la testa. La campagna assolata sfrigolava di pixel monocromatici. Duecentocinquantasei sfumature di grigio, che diventavano severe geometrie in fondo al pendio.
Villaggio di Jenovac, quattro case animate dal moto acquoso di una dozzina di puntini rossi. Calore kosovaro: vecchi e bambini, forse qualche giovane donna. Impossibile stabilirlo con quella risoluzione e a una simile distanza.
Nell’imboscata in cui erano caduti, Andreij era stato catturato e lui, Stevan, il modello più vecchio della squadra, si era beccato una pallottola nel braccio. Da allora, Mariko (Lince) gli aveva ordinato di rimanere allacciato al suo impianto ottico o a quello di Lollipop, per evitare di perdersi e rallentare la fuga degli altri. A volte, però, Stevan sfilava dal software dei compagni e si soffermava a guardare il paesaggio nel suo brodo tiepido di pixel in bianco e nero. Felci, alberi, cortecce bruciacchiate.
E ora calore, carne, donne.
Musica. A volume impossibile. Nella testa il rap sincopato di The Rockafeller Shank di Fat Boy Slim.
![]() Facevano parte di una squadra di quattro soldati, in normale missione di approvvigionamento. Avevano marciato per ore nei boschi attorno a Medvedja. Cercavano pezzi di ricambio… Poi l’imboscata, il tiro incrociato dei cecchini, Andreij che urlava. Che mandava scariche elettrostatiche, il sibilo di un fax, musica sincopata, rumore di scratching sulla manopola di una vecchia radio, nel disperato tentativo di non perdere la sintonia con i propri compagni. Stevan aveva alzato il volume del suo rap.
Facevano parte di una squadra di quattro soldati, in normale missione di approvvigionamento. Avevano marciato per ore nei boschi attorno a Medvedja. Cercavano pezzi di ricambio… Poi l’imboscata, il tiro incrociato dei cecchini, Andreij che urlava. Che mandava scariche elettrostatiche, il sibilo di un fax, musica sincopata, rumore di scratching sulla manopola di una vecchia radio, nel disperato tentativo di non perdere la sintonia con i propri compagni. Stevan aveva alzato il volume del suo rap.
***
Monaldi afferrò la mano tesa del compagno e lo aiutò a issarsi dalla fossa. L’uomo si chiamava Vincent Leclerc: si era unito alla squadra solo da due settimane, come ufficiale di collegamento del contingente francese. Era sudato e imbrattato di fango. «Non posso esserne certo, ovvio», esordì in perfetto italiano, «ma il cranio deve aver trasmesso fino a qualche giorno fa, dopo di che la memoria si è cancellata e il soldato è clinicamente deceduto».
Monaldi si guardò attorno: c’erano segni di un campo trasferito in gran fretta. Nella fossa, cinque corpi distesi a faccia in giù, la nuca scoperchiata da pallottole calibro 9. Leggermente discosto, un sesto cadavere – l’unico coi piedi scalzi – indossava uno strano patchwork di divise: pantaloni della mimetica grigioverdi, camicia kaki, elmetto da paracadutista americano, senza gradi. Mostrava segni di bruciature su polsi e caviglie, con tutta probabilità era morto sotto tortura con gli elettrodi, forse rivestito in fretta e furia e condotto lì per dargli il colpo di grazia e quindi seppellirlo con gli altri.
Merda.
«Credi che lo abbiano individuato?» Non aveva dubbi, ma ascoltare la risposta lo avrebbe aiutato a smaltire un po’ di rabbia.
![]() Leclerc si pulì le mani in un fazzoletto già lurido. «Dato il tipo di morte che gli hanno riservato, è probabile di sì. Volevano farlo parlare, forse si sono resi conto che non ci sarebbero mai riusciti e hanno cercato di mandarlo in corto con le scariche elettriche. Prima che trasferisse altrove i dati della sua memoria».
Leclerc si pulì le mani in un fazzoletto già lurido. «Dato il tipo di morte che gli hanno riservato, è probabile di sì. Volevano farlo parlare, forse si sono resi conto che non ci sarebbero mai riusciti e hanno cercato di mandarlo in corto con le scariche elettriche. Prima che trasferisse altrove i dati della sua memoria».
Alla rabbia subentrò la frustrazione per essere arrivati troppo tardi. «E neppure quello ha funzionato…»
Il francese alzò le spalle. «No». Ripose il fazzoletto in una tasca della mimetica e si avviò verso la piccola tenda da campo dove tenevano database più potenti. Carlo Monaldi si passò una mano sotto il berretto e fece scorrere le dita lungo i punti della sua unica sutura. Un lavoro perfetto: mancava soltanto una sottilissima striscia di capelli in corrispondenza della piccola protuberanza di tessuto cicatriziale.
Sarzi e Montella continuarono i rilevamenti da soli, lavorando sul cranio del militech con i portatili, alla ricerca di qualche traccia sfuggita al comando di TRANSFER MEMORY.
![]() NOTA. Il racconto “Necroware” fu pubblicato per la prima volta nel 2003, sullo Speciale Horror di Urania “In fondo al nero”, a cura di Gianfranco Nerozzi. Nell’occasione, Nerozzi – che in passato ha suonato in una rock band – chiese a ciascun autore d’inserire nel proprio racconto l’accenno a un brano musicale. Io per la mia storia scelsi il rap “The Rockafeller Shank” del Djay, produttore discografico e beatmaker inglese Fatboy Slim. Il brano, ripetuto ossessivamente nella testa del protagonista del racconto, divenne in qualche modo la colonna sonora dei Militech e diede la misura della loro inguaribile follia di zombie e di soldati votati a morire e morire e morire, per risorgere ogni volta…
NOTA. Il racconto “Necroware” fu pubblicato per la prima volta nel 2003, sullo Speciale Horror di Urania “In fondo al nero”, a cura di Gianfranco Nerozzi. Nell’occasione, Nerozzi – che in passato ha suonato in una rock band – chiese a ciascun autore d’inserire nel proprio racconto l’accenno a un brano musicale. Io per la mia storia scelsi il rap “The Rockafeller Shank” del Djay, produttore discografico e beatmaker inglese Fatboy Slim. Il brano, ripetuto ossessivamente nella testa del protagonista del racconto, divenne in qualche modo la colonna sonora dei Militech e diede la misura della loro inguaribile follia di zombie e di soldati votati a morire e morire e morire, per risorgere ogni volta…
Ascolta la canzone “The Rockafeller Shank” di Fatboy Slim.
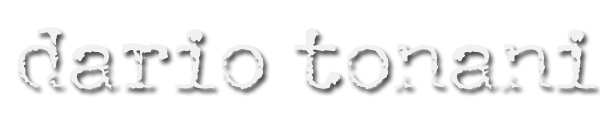

Lascia un commento